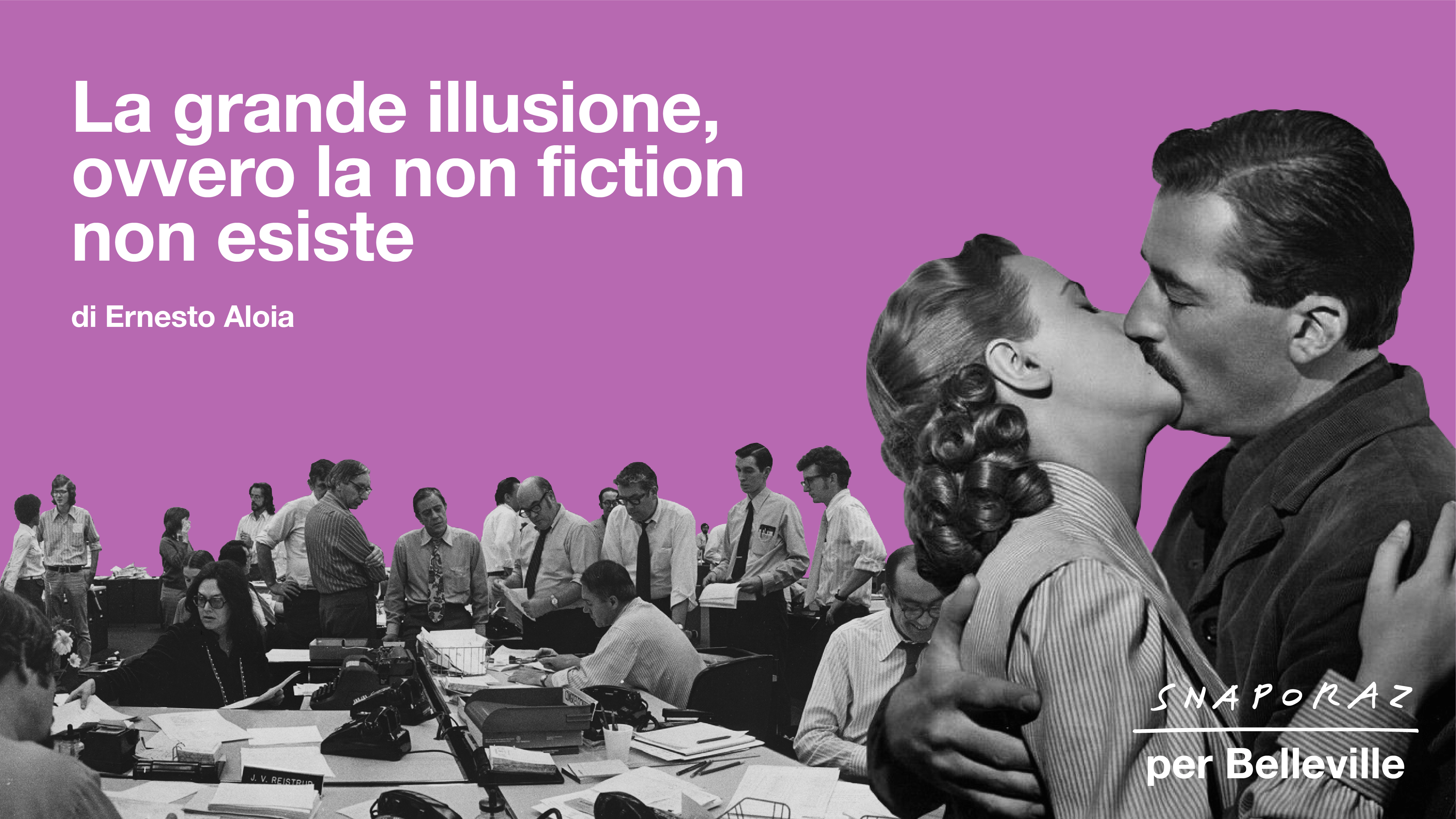Quando si è estinta la domanda su quanto c’è di autobiografico rivolta a un autore di narrativa? Nessuno ricorda con precisione. Gli storici finiranno per accordarsi su una data convenzionale, come per la caduta dell’impero romano. Quanto alla causa dell’estinzione, possiamo proporre un’ipotesi: era diventata superflua.
Quanto c’è di autobiografico in questo tuo romanzo? L’intervistatore si godeva l’imbarazzo del malcapitato autore, che qualche volta azzardava persino una percentuale tendendo, però, sempre al ribasso.
Il fatto è che a quei tempi scrittori e personaggi non andavano d’accordo. Gli autori tenevano personaggi e storie a distanza con tutti i mezzi: terze persone, narratori inaffidabili o onniscienti e impiccioni, manoscritti ritrovati, diari, lettere. Volevano che ci appassionassimo alle storie che scrivevano, ma nella maggioranza dei casi non volevano che le credessimo storie loro. Da qualche tempo – anche in questo caso occorrerebbe una data convenzionale, ma diciamo un paio di decenni – tutto questo è cambiato. Narrazioni fattuali, autobiografie, testimonianze, memorie, sono sempre esistite ma il novel – il romanzo borghese, realistico per DNA ma opera dichiaratamente di finzione – per secoli era riuscito a garantirsi un primato di prestigio. Ci si laureava veri scrittori nonostante l’autobiografia, non in virtù di quella, altrimenti si era ombelicali ed erano guai.
Poi è arrivata la fiumana non finzionale, ibrida, memoriale e fattuale. Una moltitudine, come in un quadro di Pellizza da Volpedo, e tutti facendosi avanti chiedevano a gran voce una sola cosa: di essere creduti.
Facciamo un passo indietro. Anche il tradizionale narratore realista voleva essere creduto. E, se ufficialmente aspirava alla verosimiglianza anziché alla verità, la potenza persuasiva dell’arsenale stilistico-retorico a sua disposizione talvolta era tale da trascinare il lettore appena appena naif dal terreno rispettabile dell’effetto di reale alle acque torbide della credulità. Prendiamo Giorgio Bassani. Pochi autori hanno lavorato con tanta caparbietà a fondere in un gioco continuo di dissolvenze incrociate il dato storico con la finzione. Il romanzo di Ferrara, incastonato nell’evidenza documentaria dell’ascesa del fascismo in città, è un intarsio fittissimo di rimandi. La precisione della toponomastica, il dettaglio delle descrizioni, la rete di notazioni minute – oggetti, marchi, codici linguistici, personaggi, film –, il rinvio continuo a evidenze incontestabili, genera un surplus di effetto di reale che confonde il lettore e lo lascia vagare nella terra di nessuno tra verosimiglianza e veridicità.
Nota autobiografica imbarazzante: anche a me, allora giovane ingenuo fresco di prima lettura, in un’epoca analogica, a bassa definizione e a lenta circolazione delle informazioni, sprovvista di Maps e Street View, è capitato di ritrovarmi in un torrido pomeriggio dell’agosto ferrarese al fondo di corso Ercole I d’Este a domandarmi che fine avesse fatto la Magna Domus dei Finzi-Contini, e perché mai non ne restasse traccia. (Credetemi. Ho la cartolina di un’amica che lo dimostra.)
E la Newark di Philip Roth? A volte mi sembra di conoscere Weequahic e la sua storia meglio del mio quartiere. In Nemesi racconta una epidemia di poliomielite nella Newark del 1944: è una finzione, ma quanti lettori hanno creduto che davvero la città fosse stata colpita, in quell’anno di guerra, dal morbo allora incurabile? A giudicare dalla mole di interviste, articoli, saggi che si premurano di ristabilire il dato storico alterato, non pochi.
Quanto alle narrazioni della fiumana non finzionale, ibrida, memoriale e fattuale – che aspirano non all’effetto di reale ma al riconoscimento della veridicità –, cosa fanno per essere all’altezza delle loro ambizioni? Come sperano di essere credute? Il dato più evidente è la propensione di massa per una prima persona utilizzata come strumento per regolare le modalità della comunicazione. Il passaggio dalla terza alla prima non è un semplice cambio di casella grammaticale ma una rifondazione del rapporto emotivo con il lettore che ha come conseguenza l’azzeramento prospettico: ogni percezione della distanza tra autore reale, io narrante e personaggio viene annullata. Io ci metto la faccia, dice l’autore al lettore. Tu, in cambio, fidati. Quante sofisticherie narratologiche andate in fumo.
E se questo io finito sotto i riflettori ricorre volentieri all’appello diretto alla fiducia del lettore, è anche vero che il peculiare patto narrativo richiesto dalla non fiction ha per chi scrive le sue clausole e i suoi vincoli, e il loro rispetto impone l’uso di ulteriori strategie testuali.
Nel momento in cui diventa testimone della realtà l’io nel triplice ruolo di autore, narratore e personaggio perde i suoi superpoteri voyeuristici: non avrà più il diritto di leggere nella mente dei personaggi, non conoscerà le loro motivazioni e non sarà in grado di riferirne i pensieri, non potrà più spiarli quando non agiscono in sua presenza – cosa che i narratori tradizionali facevano, con le dovute cautele, anche in prima persona, e che i lettori erano disposti ad accettare –, dunque potrà raccontarli solo facendo ricorso a formule dubitative o ipotetiche (forse X pensava che… immagino che Y credesse…) o citando a supporto fonti documentali pseudogiornalistiche. In alternativa, potrà ammettere di non saperne abbastanza – e questa confessione finirà per essere considerata dal lettore come un attestato di veridicità.
Ma c’è di più. L’accesso alla solida realtà dell’esperienza richiede la rinuncia programmatica alla facoltà della memoria creativa, dunque trasformativa e inaffidabile.
Annie Ernaux ha dichiarato di detestare Proust – e va bene, a parlare era forse la militante più che la scrittrice, e l’accusa si riferiva, con anacronismo molto à la page, all’atteggiamento di Proust verso le classi ritenute inferiori, ma è impossibile non vedere come tutta la gigantesca opera di catalogazione della propria esperienza di Ernaux si svolga all’insegna di un bisogno antiproustiano di esattezza annalistica. Per questo produce incessantemente fonti documentarie: fotografie, annotazioni, diari, film in super 8. La memoria è al servizio di una poetica della verità che si propone di bruciare ogni residuo di letteratura, tanto da abbandonare la pagina scritta per prendere la via dei filmati di famiglia con tanto di commento dell’autrice (e non è una sorpresa che molti suoi brani risultino essere una trascrizione fedele – un verbale – di quelle immagini). Ernaux vuol prendere una vita individuale – la sua – e renderla universale rinunciando a ogni diritto di proprietà. Vaste programme. L’equivalente narrativo di donare il proprio corpo alla scienza.
Bisogna riconoscere la magnanimità del proposito. La testimonianza, il documento, il resoconto fattuale ci consolano e ci rassicurano nell’epoca del deep fake e dei fatti alternativi. Ma bisognerebbe, forse, riconoscere anche il velleitarismo delle poetiche della verità. Non possiamo liberarci della letteratura perché la letteratura è dentro di noi. Mettiamoci alla scrivania e proviamo a raccontare qualcosa che ci è accaduto davvero. Cosa ci succede? Né più né meno di quello che accade quando scriviamo di qualsiasi altra cosa, avvenimenti immaginari compresi: siamo noi a esprimerci attraverso il linguaggio, ma nello stesso tempo è il linguaggio che si esprime attraverso di noi. Non possiamo farne a meno. La lingua – in questo caso la lingua della letteratura – manifesta attraverso di noi le sue strutture profonde, gli archetipi narrativi costringono le nostre parole (e prima ancora le nostre percezioni) a disporsi secondo i loro schemi; e le parole, a loro volta, hanno una storia che viene chiamata continuamente in causa, risonanze che non è possibile ignorare. Noi vogliamo raccontare la vita ma la vita imita l’arte (e l’alternativa, l’aveva capito Woody Allen moltissimi anni fa, è la cattiva televisione). Non esiste una scrittura innocente. È un’illusione. La liberazione dalla letteratura passa esclusivamente attraverso una maggiore consapevolezza della letteratura. Per questo, se ammettiamo la grandezza del tentativo di Ernaux, qui citata ad esempio per l’estremismo della sua vocazione documentale, non dovremmo ignorare i limiti di una poetica fondata su un concetto pericolante come la verità. Tutto ciò che finisce su una pagina scritta è fittizio. La scrittura finge sempre – soprattutto quando non lo dichiara – e noi, soli davanti al testo, non siamo in grado di smascherarla.